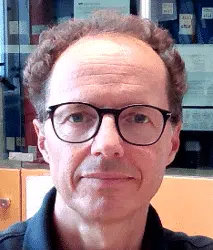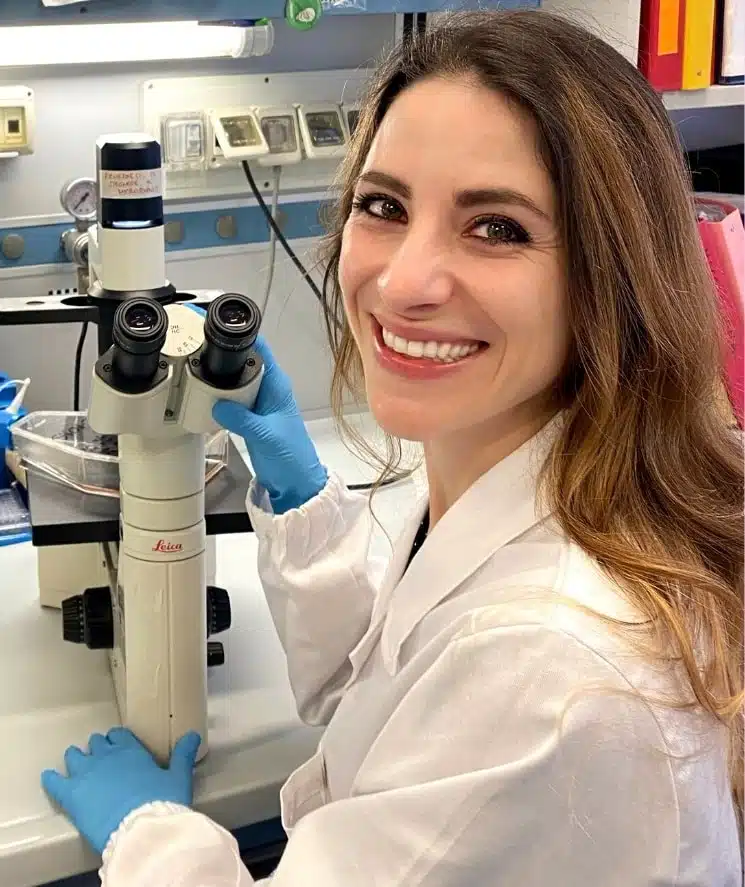L’UOC Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica (IDMO) effettua analisi diagnostiche e conduce progetti di ricerca su approcci diagnostici innovativi in diversi ambiti dell’oncologia e dell’immunologia, dalla prevenzione alla diagnosi, e dalla terapia al monitoraggio della risposta, mediante l’utilizzo di diverse e numerose metodologie. L’esperienza e la competenza degli operatori permette una costante innovazione delle analisi a fini diagnostici e/o prognostici, attraverso la messa a punto di metodiche dimostratesi utili nel corso di studi sperimentali evidence-based, che vengono quindi rese disponibili in anticipo rispetto alla commercializzazione.
Vocazione dell’IDMO è la messa a punto, standardizzazione ed esecuzione di indagini molecolari e approcci innovativi che consentano una diagnostica avanzata, un follow-up e una terapia personalizzata dei pazienti con neoplasie solide ed ematologiche. Questo obiettivo primario viene perseguito essenzialmente attraverso:
- la comprensione e il rispetto delle esigenze e delle aspettative di un’utenza particolarmente sensibile quale quella dei pazienti oncologici e dei loro familiari;
- la simbiosi continua tra ricerca e assistenza, perseguita nella convinzione che una buona pratica clinica non possa essere dissociata da una buona ricerca clinica e preclinica;
- l’aggiornamento continuo del personale sui temi di maggior rilievo immunologico e oncologico, attraverso la frequentazione di seminari, corsi e congressi e collaborazioni strette e costanti con i laboratori di riferimento in campo nazionale ed internazionale;
- il training puntiglioso del personale tecnico e l’osservanza di rigorosi protocolli esecutivi nelle diverse tecniche laboratoristiche, nonché delle più rigide norme di sicurezza per la protezione degli operatori dal biohazard biologico;
- la stretta collaborazione con gli oncologi e gli ematologi medici padovani e veneti, nell’ottica della massima diffusione sul territorio della diagnostica più avanzata;
- la sinergia con l’Università e l’Azienda Ospedale Università di Padova, nella prospettiva di un’implementazione delle rispettive competenze.
Alla UOC Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica afferisce la UOS Tumori eredo-familiari della mammella/ovaio (Dott. Montagna).